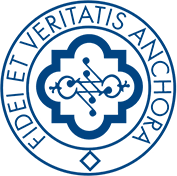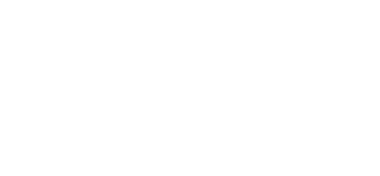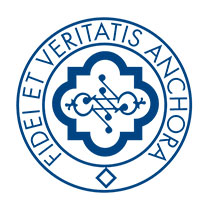CERCA
Gli usi civici e la vendita forzata
Autore:
Armanda Ilaria Miceli
03/02/2026
Lo studio si propone fornire alcune indicazioni chiare in ordine al regime circolatorio degli immobili gravati di usi civici, valorizzando il sistema normativo vigente, alla luce delle recenti sentenze Cass. Sezioni Unite civili sent. 10 maggio 2023 n. 12570 e C. Cost. Sent. 15 giugno 2023 n.119.
Il tema viene affrontato con particolare riferimento alle vendite forzate, verificando le conseguenze dell’emersione dell’esistenza di usi civici su beni oggetto delle stesse, anche avuto riguardo al momento della procedura nell’ambito della quale tale accertamento viene effettuato e cercando di mettere a fuoco modalità dell’accertamento, conseguenze e rimedi.
Studio n.11-2025/PC Autorizzazione alla vendita di beni ereditari appartenenti ad incapaci e necessità dell’inventario
Autore:
Roberto de Falco
28/01/2026
Lo studio affronta il problema delle interferenze tra regime dell’autorizzazione alla vendita dei beni ereditari, quando l’eredità appartenga a soggetti incapaci, e redazione dell’inventario. Muovendo dal quadro normativo (artt. 747 c.p.c., 471 ss. c.c. e riforma Cartabia), si chiarisce innanzitutto il quadro normativo in tema di autorizzazione alla vendita di beni ereditari, anche in ordine alla competenza. Indi si affronta il tema del ruolo dell’inventario nella procedura di accettazione beneficiata da parte degli incapaci, chiarendo, anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 31310/2024, che la dichiarazione di accettazione beneficiata produce comunque l’acquisto della qualità di erede, anche prima della formazione dell’inventario. Ne segue che l’inventario non costituisce un presupposto indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita ex art. 747 c.p.c., ferma restando la facoltà del soggetto autorizzante (giudice o notaio) di richiederne la formazione in via istruttoria, qualora ritenuto utile alla valutazione degli interessi dei creditori e dell’incapace.
Studio n.61-2024/c L’annotazione dell’accollo liberatorio e la “continuità” dell’ipoteca
Autore:
Ettore William Di Mauro
16/01/2026
Mentre la modifica dal lato attivo del rapporto (ossia la modifica del creditore) impone l’annotazione con conseguente opponibilità ai terzi, perché l’interesse perseguito è già ritenuto meritevole dalla norma (escludere il precedente titolare dall’esercizio di qualsiasi potere attinente al rapporto ipotecario), nel caso di modifica dal lato passivo del rapporto (ossia la modifica del debitore), invece, occorre valutare se quella determinata norma possa essere considerata necessaria a proteggere interessi, diversi da quelli espressamente previsti, ma meritevoli in quanto rilevanti per il caso concreto, poiché il debitore è sempre tenuto ad adempiere la propria obbligazione indipendentemente dal creditore. Il presente studio muove da questo presupposto per verificare le ripercussioni dell’assenza di obbligatorietà di annotazione sulla pienezza dell’originaria iscrizione dell’ipoteca a garanzia del credito quando avviene una modifica dal lato passivo del rapporto obbligatorio in ipotesi di accollo esterno liberatorio.
I risultati permettono di ritenere che la mancata annotazione dell’accollo liberatorio, sia condizionato sia incondizionato, indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di successione nel debito o di novazione soggettiva, non pone particolari conseguenze sulla pienezza della garanzia e il creditore potrà rivalersi sulla garanzia reale per l’intero importo dovuto e sul complessivo valore del bene, trasferendosi il tutto in capo al debitore che si è accollato l’intero debito.
Resta comunque ammissibile un’annotazione facoltativa (con funzione meramente informativa), specialmente per l’ipotesi di accollo esterno liberatorio condizionato, in quanto permetterebbe una semplificazione probatoria sia per il creditore sia per il debitore liberato, oltre a rendere immediatamente informati tutti coloro che avrebbero rapporti con il bene oggetto di ipoteca, in forza del principio di massima chiarezza delle operazioni giuridiche ed economiche.
Tuttavia, almeno per il momento, le prassi delle Conservatorie sembrano rimanere ancorate sul principio di tassatività degli atti soggetti ad annotazione, con la conseguenza che, seppure ammissibile in linea teorica, la richiesta di annotazione dell’accollo liberatorio potrebbe ricevere un rifiuto.
Studio n.58-2025/T OSSERVAZIONI A MARGINE DELLE ISTRUZIONI MINISTERIALI AL NUOVO MODELLO DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE TELEMATICA A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
Autore:
Ugo Friedmann – Simone Ghinassi – Adriano Pischetola
15/01/2026
Lo studio esamina gli aspetti problematici che si sono presentati nella prassi applicativa a seguito dell’introduzione del modello di dichiarazione di successione telematico e della successiva e più recente introduzione, tramite detto modello, della totale autoliquidazione dell’imposta (D.Lgs. 139/2024).
Studio n. 37-2025c clausole dei regolamenti contrattuali di condominio predisposti dai costruttori e disposizioni inderogabili di legge
Autore:
Maurizio Corona e Davide Scipione Spitaleri
14/11/2025
Lo studio, esaminata la distinzione tra regolamento di condominio assembleare e contrattuale e i limiti posti all’autonomia privata dall’art. 1138, comma 4, ultima parte, c.c., offre un’ampia analisi delle numerose clausole contenute nei regolamenti contrattuali predisposti dal costruttore dell’edificio in contrasto con disposizioni inderogabili di legge e si chiude con la trattazione delle complesse problematiche relative alla vincolatività e all’opponibilità di tali regolamenti alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
Studio n. 227-2024/P Distanze legali nel sistema della proprietà edilizia e nel T.U. dell’edilizia, D.P.R. 380/2001 ART. 2 BIS
Autore:
Filippo Clericò
16/09/2025
Lo studio prende in esame la disciplina delle distanze legali nell’ambito della complessiva regolamentazione che discende dal Codice Civile, dalla Legge urbanistica 1150/1942, dal D.M. 1444/1968, e dal D.P.R. 380/2001. In particolare ci si sofferma sulla ratio e sui presupposti per l’applicazione delle norme inerenti alle distanze, sia dalle costruzioni che dai confini, nonché sul ruolo e gli spazi operativi riservati alle regioni e alla pianificazione comunale. In particolare, viene analizzato il nuovo art. 2 bis del D.P.R. 380/2001, puntualizzando le deroghe che possono essere operate dalle Regioni al sistema delle distanze, e la disciplina nelle fattispecie di “demolizione e ricostruzione”. Lo studio, dato il succedersi nella materia di interventi legislativi, dedica un paragrafo al fenomeno della successione di leggi nel tempo e si conclude con delle osservazioni circa il ruolo dell’autonomia privata nell’ambito delle distanze.
Studio n. 04-2025/C CONVENZIONI MATRIMONIALI ATIPICHE E REGIMI PATRIMONIALI ATIPIC
Autore:
Fulvio Mecenate
19/08/2025
Non è revocabile in dubbio, per ragioni storiche (il principio della «libertà degli sposi», dal punto di vista patrimoniale, come applicazione del favor matrimonii), sistematiche (la convenzione matrimoniale come vero e proprio «contratto») e persino testuali (art. 159; art. 161) che possano configurarsi convenzioni matrimoniali atipiche, istitutive di regimi atipici.
Quale esempio paradigmatico di convenzione (eventualmente) atipica, istitutiva di un regime (eventualmente) atipico, possiamo considerare l’accordo tra coniugi che dia vita ad una «comunione soltanto differita», escludendo quella immediata.
La «comunione soltanto differita» potrebbe essere una comunione modificata ex art. 210 c.c. (se la convenzione si limita solo ad escludere la comunione immediata, confermando i caratteri di quella differita); ovvero un regime autonomo e atipico (se la stessa comunione differita è sensibilmente rimodulata, per es. escludendo ogni contitolarità reale riducendosi a situazioni puramente obbligatorie). La questione incide sull’interpretazione della convenzione, sulle conseguenze della nullità parziale e sui limiti imposti dall’art. 210 c.c.
Come regime in sé, la «comunione soltanto differita», proprio perché «differita», esclude la comunione coniugale attuale, ed è un regime puramente separatista, in cui ciascuno amministra e dispone dei beni personali e «propri». È insomma una separazione dei beni «temperata» dall’insorgere di reciproci diritti alla cessazione del regime.
La «Zugewinngemeinschaft»: La situazione puramente obbligatoria potrebbe consistere in una liquidazione pecuniaria pari alla metà della differenza tra gli incrementi dei patrimoni dei due partners verificatisi in corso di matrimonio. In questo modo si verrebbe a creare, per via convenzionale, una situazione vicina alla Zugewinngemeinschaft di diritto tedesco.
La «separazione temperata prematrimoniale»: la «separazione temperata» potrebbe essere l’oggetto di una convenzione matrimoniale stipulata prima del matrimonio/un.civile. E in questo modo costituirebbe in via anticipata il diritto ad una prestazione solidaristica predeterminabile in caso di scioglimento del rapporto. Non sarebbe un patto prematrimoniale, perché al contrario proprio di «patto nuziale» si tratterebbe, ben distinto da esso anche per il fatto dell’indeterminatezza del soggetto debitore, dell’an e quantum della prestazione; ma con la capacità di soddisfare in sé, in piena legittimità e meritevolezza, una finalità solidaristica, in vece ed al posto dei (controversi) patti prematrimoniali.
La pubblicità, tramite annotamento, è realizzata dagli Uffici tramite l’indicazione della presenza di una «comunione convenzionale». La conoscibilità del concreto regime adottato è rimessa all’ottenimento di copia del titolo dal Notaio rogante.
Studio n. 82-2024/C – La pubblicità della comunione convenzionale
Autore:
Andrea Ferrari e Michele Labriola
05/08/2025
Il presente studio completa il precedente in materia di comunione convenzionale, occupandosi esclusivamente dell’aspetto pubblicitario.
Acclarato che tutte le convenzioni costitutive di una comunione convenzionale, sia programmatiche che dispositive, devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio ai fini dell’opponibilità delle stesse, lo studio si concentra sull’analisi dell’articolo 2647 codice civile, norma che impone la formalità della trascrizione, avente funzione di pubblicità notizia, concludendo nel senso che rientrano nel perimetro applicativo di tale disposizione esclusivamente le convenzioni di riduzione, sia dispositive, disciplinate dal primo comma, che programmatiche, disciplinate dal secondo comma, mentre le convenzioni di ampliamento, sia di tipo dispositivo che di tipo programmatico, non devono essere oggetto di autonoma trascrizione ulteriore rispetto a quella riguardante l’effetto traslativo.